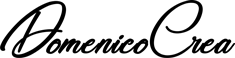Il calendario romano (II parte)
I Romani nella indicazione delle ore della giornata erano piuttosto vaghi e generici.
Essi ricorrevano spesso a riferimenti indeterminati, come prima luce (sul far del giorno), multo die (= a giorno avanzato), sub vespertini (verso sera), de multa nocte (nel cuore della notte), ecc.
Il giorno, tuttavia, era diviso in due parti, “dies” (dall’alba al tramonto) e “NOX” (dal tramonto all’alba).
II dies era poi approssimativamente suddiviso in 12 parti, dette horae.
Ne conseguiva che, con il variare delle stagioni, variava la durata di ciascuna hora e che, almeno in astratto, solo nell’equinozio di primavera (21 marzo) e nell’equinozio di autunno (23 settembre), quando cioè il sole sorge alle 6 e tramonta alle 18, l’hora era esattamente di 60′.
Nei due equinozi, infatti, l’hora prima andava dalle 6 alle 7, l’hora secunda dalle 7 alle 8 e così via fino all’ hora duodecima, che andava dalle 17 alle 18.
La nox era divisa in quattro parti, dette vigiliae in riferimento ai turni di guardia compiuti dalle sentinelle (vigiliae, arum).
Anche la durata della vigilia variava con il variare delle stagioni: era massima di inverno e minima d’estate.
Negli equinozi ogni vigilia era teoricamente di tre ore:
prima vigilia : dalle 18 alle 21
secunda vigilia: dalle 21 alle 24
tenia vigilia : dalle 24 alle 3
quarta vigilia : dalle 3 alle 6
La divisione del mese in settimane è di origine ebraica; essa era pressoché ignota ai Romani che la conobbero forse solo verso il 1° secolo a. C. e che l’adottarono molto più tardi, al tempo della definitiva affermazione del Cristianesimo.
I giorni della settimana ( hebdòmas, àdis, f.) presero nome dai corpi celesti:
dies Solis (dies dominìcus, nel linguaggio ecclesiastico) = domenica;
dies Lunae = lunedì;
dies Martis = martedì;
dies Mercurii = mercoledì;
dies Iovis = giovedì;
dies Venèris = venerdì;
dies Saturni (dies Sabbati, nel rito ebraico) = sabato.
La tradizione, come già detto, attribuisce al re Numa Pompilio (715-672 a. C.) la divisione dell’anno in 355 giorni e in 12 mesi di varia durata (31, 29 e 28 giorni).
L’anno di tale durata era però notevolmente diverso da quello solare; per ristabilire la coincidenza con l’anno solare fu pertanto stabilito che, a cura dei pontefici massimi, si intercalasse ogni due anni, dopo il 23 febbraio, un periodo, una volta di 22 giorni e la successiva di 23 giorni.
Al mese di febbraio poi, nell’anno intercalare, venivano tolti 5 giorni; questi erano aggiunti ai 22 (o ai 23) giorni del periodo intercalare e formavano così un intero mese di 27 (o di 28) giorni: tale mese era detto intercalaris o mercedonius
In tal modo, però, l’anno finiva con l’essere diviso in 366 giorni e 1/4 e aveva così un giorno più del reale.
Nel 46 a. C., Giulio Cesare, quale pontefice massimo, dette incarico al matematico alessandrino Sosigene di provvedere ad una riforma del calendario, tanto più che, per l’omissione di alcuni mesi intercalari, l’anno ufficiale era in anticipo su quello solare di circa 90 giorni.
Furono prima di tutto inseriti in quell’anno tre mesi, il mercedonius, dopo febbraio, e altri due tra novembre e dicembre.
Si portò poi l’anno a 365 giorni, distribuiti nei 12 mesi, ciascuno di durata pari a quella ancora oggi mantenuta.
Per ricuperare, infine, le 6 ore circa di differenza con l’anno solare, fu stabilito che ogni quattro anni si inserisse, tra il 24 febbraio ( dies sextus ante Kalendas Maias ) e il 25 un giorno detto bis sextus (onde il nostro «anno bisestile»).
Ma il calendario giuliano non teneva conto che la differenza tra anno ufficiale e anno solare non era di 6 ore, ma di 5 ore, 48′, 46″: fu pertanto necessaria un’ulteriore riforma, che fu poi quella voluta da papa Gregorio XIII, nel 1582 (calendario gregoriano), di cui parlerò in seguito.