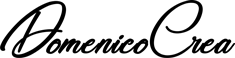Gentili Signore e Signori buonasera, ringrazio anzitutto Enrica Marelli, instancabile e meravigliosa organizzatrice di questa XIII edizione del Premio letterario Europeo “Città di Scalea”, per avermi affidato il gradito incarico di commentare brevemente il libro : IL NOME DI MARINA, di Roselina Salemi Appena ho finito di leggere questo libro, ho avvertito subito il bisogno di collocarlo in una precisa dimensione spazio-temporale. Ma mentre per la prima dimensione la mia curiosità è stata facilmente appagata da un’occhiata ad una cartina geografica della Sicilia, per la seconda, pur rileggendo il libro con maggior attenzione, ho trovato soltanto due indicazioni di una precisa data: 1966, scontro con i poteri forti e 1992, anno dell’uccisione del protagonista. Ho avuto perciò la sensazione che la vicenda assumesse una dimensione quasi atemporale, fortemente emblematica, e perciò confacente a tante altre analoghe situazioni, che ciclicamente, purtroppo, ancor oggi al Sud si verificano. Nello stesso periodo, infatti, sull’onda di un improbabile sviluppo economico-sociale, si è verificato il saccheggio e quindi il degrado di tante coste del sud Italia, sacrificate al miraggio dell’ occupazione e oggetto di selvaggia cementificazione per una certa industrializzazione inquinante o una mostruosa inurbazione. Perciò il percorso storico dell’io narrante, fatto come lui dice di carne e sangue, un uomo davvero coraggioso che combatte la Mafia e i politici collusi, si dipana tra fatti ed avvenimenti ben concreti e reali, mistificati sol quel tanto dall’Autrice per non essere evidentemente collegati a persone realmente esistite. In definitiva, questo libro è la storia di un sentito, profondo, sviscerato, immenso amore. E non per una donna, pur se diverse il protagonista afferma di averne amato, ma per una striscia di terra e di sabbia con poche case, il suo loco natìo, Marina di Melilli, ed in generale per la propria terra, la Sicilia, distrutta nei suoi elementi storico-culturali e paesaggistico-ambientali in nome del Progresso. Attraverso la tecnica già nota del flash- bach, ma con l’escamotage dell’io narrante già morto, la Salemi riesce ad esprimere sin dalle prime pagine l’indistruttibile coappartenenza di ogni uomo ai luoghi della propria infanzia ed ai sogni di prima gioventù, soprattutto nell’esistenza di un uomo del Sud, capace di apprezzare il retaggio più profondo di antiche civiltà (fenicia, magno-greca, romana, araba, normanna, sveva, angioina, aragonese,ecc.) che hanno caratterizzato le vicende della Sicilia. La Salemi, ovvero l’io narrante, le avverte dentro di sé come un patrimonio culturale che toglie il respiro, come vestigia di Storia, di Miti, di Eroi, di Leggende, di Dei, comunque di uomini straordinari che quei luoghi affascinanti scelsero come dimora. Grandi o piccole vite, lontane o vicine nel tempo, che lasciarono in questi luoghi qualche orma indelebile di sé.(pag. 18) Nei miei vagabondaggi lungo la costa avevo scoperto segreti che stavano sotto gli occhi di tutti, ma nessuno vedeva. Oltre Punta Magnisi, tra le rovine di una città greca e i resti di ville romane, avevo trovato una serie di mosaici sbiaditi, ma ancora bellissimi. C’erano un suonatore di flauto con i capelli acconciati in riccioli perfetti e una donna seduta che si specchiava. Lei aveva un vestito sparso di pagliuzze d’oro, una lunga, curatissima treccia, la bocca grande, mossa da un piccolo sorriso, gli occhi concentrati sullo specchio. Chissà che cosa vede, pensavo ogni volta. Avrei voluto che il mosaico non fosse così rovinato e mi permettesse di guardare dentro lo specchio, dentro la vita di quella donna morta chissà quanti secoli fa. Forse la spiaggia ha raccolto i suoi passi, proprio come i miei. Forse anche lei si è fatta le mie stesse domande. Forse anche lei, come me, non ha trovato risposte. Emerge così il sostrato, l’humus di quel profondo coinvolgimento culturale, e politico, il grido di dolore per lo scempio perpetrato, che solo a tratti, come all’inizio di alcuni capitoli (“apparizioni”, Rimedi contro il mal d’amore,) o all’interno di altri, si stempera in una fascinazione verbale che ammalia il lettore, soprattutto nella descrizione puntuale delle peculiarità naturalistiche ed artistiche di quella terra.(pag.12) Marina di Melilli. Onde e spiagge silenziose, voci di bambini, canzoni, lagune e polvere d’ambra. Ville romane e fenicotteri rosa, file di oleandri e relitti fantastici. Dune punteggiate da minuscoli fiori blu che chiamavamo “occhi d’angelo”.. C’era la chiesa, costruita con i nostri soldi, l’asilo e là in fondo, dove la strada polverosa costeggiava un pezzo di scogliera c’erano le ville dei ricchi, con le terrazze per le feste da ballo all’aperto e le tettoie sommerse dai rampicanti. C’erano aiuole e fontane. Gelsomino, pitosforo e gardenia, datura, garofano e camelia, una litania di fiori primaverili mi torna sulle labbra, insieme con il nettare delle campanule che succhiavo, sdraiato sull’erba. Ed ancora l’intento polemico-politico, di denuncia precisa e puntuale degli intrecci politico-mafiosi, sembra lontanarsi attraverso brevi divagazioni su episodi di vita vissuti dall’io narrante che sembrano distoglierci dalla problematica fondamentale, che invece nel finale riacquista la propria dimensione drammatica, da tragedia greca, che ci lascia con l’amaro in bocca. E questo continuo trapasso tra realtà e favola, tra vita vissuta e sogno inappagato, tra rivalutazione di un patrimonio artistico-ambientale e lo scempio perpetrato, spezza frequentemente la monotonia di un’indagine giornalistica puntuale ed incalzante. Ma questo libro è godibilissimo per tanti altri bozzetti siciliani che s’intersecano con la vicenda del protagonista. Come il capitolo sui rimedi d’amore, o quello sui petali di rose con il dissidio Fede-Ragione, o quello sul Mago, con la teoria di un ineluttabile destino, o lo stupore contagioso dello straniero Debray dinanzi alle bellezze artistiche del passato, che l’Autrice così descrive (pag. 86-87)…. A Noto era rimasto strabiliato da un palazzo barocco con sei balconi sorretti da leoni, draghi alati, angeli e sirene, cariatidi visionarie commissionate da un principe puntiglioso, per incatenare nella pietra i propri incubi, riservando ai sogni felici i colori dei saloni affacciati sul cortile millenario dove secoli prima si era fermato il galoppo dei purosangue arabi. Il principe aveva ancora le chiavi e senza parlare aveva aperto la porta di comunicazione tra l’appartamento borghese dove abitava, nell’ala povera del palazzo, e le stanze costruite dal suo antenato Giacomo Castiglione di Villagrazia. Ecco il salone del biliardo con il soffitto rosa dipinto di rose, ecco il salotto rosso con le cornici dorate, il salotto giallo di damasco abbagliante con il suo pianoforte silenzioso da mezzo secolo e il soffitto affrescato con liuti flauti corni tamburelli perché chiunque lo riconoscesse come lo spazio riservato alla musica, ecco il salone delle feste, decorato come se fosse un padiglione all’aperto, con tende gonfie di vento e festoni di fiori, angeli, spighe, cesti di frutta e, lungo la cornice, i simboli delle cose che più amava: la caccia, la pesca, l’amore e la scienza. Incredibilmente, il principe e l’ingegnere si erano ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda, innamorati di un passato che i Villagrazia avevano perso e Oberon Debray non aveva mai avuto. Eppure quell’uomo aveva capito molte cose di noi, la voglia di crogiolarci in una grandezza che non è più, l’anima barocca che ci sostiene, la vita è una facciata di cattedrale, tufo tenero incendiato dal sole, splendida fuori e dentro devastata. Aveva visto altari spagnoli di legno e vetro, lapidi incastonate nei pavimenti delle chiese che magnificavano le virtù di nobildonne ormai polvere, di guerrieri normanni che avevano perso le radici nordiche dei loro cognomi per addolcirsi nelle nostre valli, aveva copiato stemmi di casati estinti, la spiga e la spada, la falce il pesce la luna, aveva accarezzato le criniere di leoni medievali sopravvissuti a crolli e frane. Qui il linguaggio, nel libro solo a tratti crudo, diventa più aulico, classicheggiante, comunque sempre fluido, discorsivo, suadente. E’ un libro affascinante, che si legge d’un fiato, poiché dosa sapientemente favola e realtà, passato e presente, con immagini a volte icastiche a volte sfumate che avvincono il lettore. I personaggi sono ben tratteggiati, anche nei loro risvolti psicologici, e l’Autrice, con affetto e simpatia, ce li fa sentire vicini. Complimenti alla brava giornalista ed all’ottima scrittrice. Ma la tematica trattata mi obbliga a seguitare alcune giunte, ovvero ad esprimere delle personali riflessioni per approfondire alcune questioni. Presumo, poiché ignoro la sua biografia, che l’Autrice sia la giornalista che ascoltò pazientemente l’io narrante e che quindi si sia nutrita da tempo, per la diretta conoscenza del protagonista, di questo sacro furore ecologista e non sia stata folgorata sol da poco sulla via di Damasco. Ma ciò che vorrei sapere, in quanto dal libro non sono riuscito a capirlo, è se, quasi filosoficamente, Ella neghi tout-court l’idea di un Progresso indusriale al sud, persino di un progresso compatibile, nella difesa puntigliosa di uno statu quo ante già compromesso. O se l’Autrice è, fatalisticamente, l’ultima discendente del Principe di Salina, che nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nel suo colloquio con l’emissario piemontese Chevalley, esprime taglienti giudizi sui siciliani: ed ancora i siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. Gradirei qualche chiarificazione in tal senso dell’Autrice. Grazie e buona serata a tutti. Scalea, 30 Settembre 2006
Leave a commentAssoc culturale “LAVINIUM” – Premio letterario “Città di Scalea – Presentaz. del libro poi vincitore
Articoli Simili
- Related Articles
- More from Author