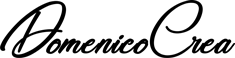Il tema della sera e della notte:Leopardi: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Nei lontani anni di Insegnante nei Licei, mi ha sempre affascinato questo Canto, che rileggo ogni tanto con vero piacere, e perciò mi permetto di esternare alcune mie impressioni e le intuizioni di alcuni autorevoli critici .
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi Ia sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.
Sorge in sul primo albore,
move la greggia oltre pel campo, e vede
greggi, fontane ed erbe;
poi stanco si riposa in su la sera:
altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,
per sassi acuti ed alta rena, e fratte,
aì vento, alla tempesta, e quando avvampal’ora, e quando poi gela
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e più e più s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colà dove la via
e dove il tanto affaticar fu volto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto oblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.
Nasce l’uomo a fatica,
ed è rischio di morte il nascimento
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
l’uno e l’altro il sostiene,e via pur sempre con atti e con parole
studiasi fargli core,
e consolarlo dell’umano stato:
altro ufficio più grato
non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
perché reggere in vita
chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?
lntatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei
E forse del mio dir Poco ti cale’.
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
che sì pensosa sei, tu forse intendi
questo viver terreno,
il patir nostro, il sospirar, che sia;
che. sia questo morir, questo supremo
scolorar del sembiante
e perir dalla terra, e venir meno
ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
il perché delle cose e vedi il frutto
del mattin, della sera,
del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
rida la primavera,
a chi giovi l‘ardore, e che procacci
il_verno coi suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
che son celare al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
star così muta in sul deserto piano,
che, in suo giro lonrano, al ciel confina;
ovver con la mia greggia
seguirmì viaggiando a mano a mano;
e quando miro in cielo arder le stelle,
dico fra me pensando:
a che tante facelle?
Che fa l‘aria infinita, e quel profondo
infinito seren? che vuol dir questa
solitudine immensa? Ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
smisurata e superba,
e dell’innumerabile famiglia;
poi di tanto adoprar, di tanti moti
d’ogni celeste. ogni terrena cosa,
girando senza posa,
per tornar sempre Ià donde son mosse:
uso alcuno, alcun frutto
indovlnar non so. Ma tu per certo,
giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
che degli eterni giri,
che dell’esser mio frale,
qualche bene o contento
avrà fors’altri; a me la vita è male.
O greggia mia che posi, oh te beata,
che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
quasi libera vai;
ch’ogni stento, ogni danno,
ogni estremo timor subito scordi;
ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
tu se’ queta e contenta;
e gran parte dell’anno
senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra I’erbe, all’ombra,
e un fastidio m’ingombra
la mente, ed uno spron quasi mi punge
sì che, sedendo, più che mai son lunge
da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
e non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
non so già dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
dimmi: perché giacendo
a bell’agio, ozioso,
s’appaga ogni animale;
me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?
Forse s’avess’io l’ale
da volar su le nubi,
e noverar le stelle ad una ad una,
o come il tuono errar di giogo in giogo,
più felice sarei, dolce mia greggia,
più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
forse in qual forma, in quale
stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dì natale.
Il contenuto del Canto notturno è, in estrema sintesi, questo: la vita umana, e forse quella di tutti gli esseri, è infelice; tutta la vita universale è inutile o incomprensibile: partendo da queste premesse, si è subito portati a pensare che esso esprima una negazione totale dell’esistere. Ma non è affatto così!
Malgrado alcune affermazioni indubbiamente negative ( è funesto a chi nasce il dì natale) nelle (logiche?) meditazioni balena una certa attesa di una risposta, forse positiva, della luna alle stringenti domande ( E tu certo comprendi/il perché delle cose….).
La prima particolarità che si nota è che il Poeta parla attraverso la figura di un pastore, immaginato vagante in un deserto sconfinato, molto lontano dall’ambiente e dal paesaggio della sua Recanati.
La figura del pastore, rileva il Binni, . [1]
Questi argomenti pare siano stati suggeriti al Poeta dalla lettura di un viaggio in Asia centrale compiuto dal barone Meyendorff, di cui alcune frasi erano state riportate nello Zibaldone nel 1828, mentre il Canto fu composto tra l’Ottobre del 1829 e l’Aprile 1830.
Indubbiamente Egli si serve di un espediente letterario, in quanto la naturalità del personaggio consente al Poeta di svolgere alcune meditazioni dal tono innocente: << situazione originalissima », diceva il De Sanctis,
La prima strofa si articola in una alternanza fra la descrizione dell'astro e quella della vita umana fino a stabilire una similitudine fra il macrocosmo (la natura) e il microcosmo (l’uomo).
Negli ultimi versi della strofa (16-20), Leopardi si interroga prima sul significato dell'esistenza in generale, poi sul suo scopo con due domande retoriche che denotano una visione fortemente pessimistica, in cui non esiste differenza fra creature mortali e corpi immortali di fronte all'assurdo vuoto che domina ogni forma di esistenza.
Nei vv. 2l-36 la rappresentazione dell'uomo accentua gli aspetti negativi dell'esistenza: l‘individuo è colto nell'età più ingrata, la vecchiaia,( vecchierel bianco, infermo è ripreso dal Petrarca: Movesi il vecchierel canuto e bianco ) fisicamente (infermo) e materialmente inadeguato (mezzo vestito e scalzo), oppresso da mille angosce mentre si affretta con difficoltà in mezzo ad una natura di cui sono evidenziati gli aspetti ostili ed esasperati.
Il senso di assurdità della vita nasce dal contrasto fra il manifesto sforzo dell'individuo, che sembra muoversi verso un fine ben preciso e, per raggiungerlo, supera ogni ostacolo a prezzo di grandi sofferenze, e lo svelamento del fine stesso dell'esistenza, cioè la morte, il nulla, in cui l'uomo precipita sprofondando in un oblio che conferma la futilità della vita.
Scriveva nello Zibaldone: [2] (Zib., 68, 3).
La morte rappresenta per Leopardi una presenza essenziale, insita nel momento stesso della nascita, della vita, umana e non, che sinistramente accompagna tutta la nostra esistenza.
O greggia mia..(vv. 56) : Il processo di svelamento della nullità e del male intrinseci all'esistenza umana raggiunge il suo culmine in questa strofa, con il ribaltamento dell'opinione comune secondo la quale I'uomo sarebbe superiore a tutte le altre creature.
Qui, la sua superiorità intellettuale si risolve nell'angoscia che necessariamente il solo fatto di pensare porta nella sua esistenza, e nell'assurdità del “tedio” che racchiude i1 paradosso doloroso della vita umana.
Egli, infatti, afferma : . [3] (Zibaldone, 4043).
Importante per capire il pensiero leopardiano ritengo quanto scrive Aldo Budriesi in un suo saggio:
Nel Canto notturno, invece, il tempo si riduce ad un punto presente eternizzato che riproduce in modo più scarno, quasi nella sua nudità essenziale, la vita umana.
Di qui il sostanziale senso di immobilità e freddezza di questa lirica, dove il rapporto con la realtà sociale è del tutto assente così da generare un'impressione sostanzialmente antivitale, di gelida astrazione che cancella quel tanto di rassicurante che era fornito dall'intonazione idillica.
Il tema centrale della lirica è, ancora una volta, una lucida analisi dell'esistenza, vista come male assoluto, perché, anche al di là del movimento sempre frustrato del desiderio, al suo centro non vi è che la e un senso di assurdità.
Il rapporto fra l'Io e la Natura si spoglia di ogni carattere affettivo: non solo le domande del pastore restano senza risposta, ma la luna stessa, questo simbolo eufemizzato della legge cosmica, è vergine, intatto, una giovinetta immortale, non toccata dalle sventure dell'uomo.
> [4]
I pensieri sulla vanità del tutto, i lamenti sull’infelicità umana che troviamo nel canto, non sono atteggiamenti esclusivi e originali del Leopardi.
Nuovo però è l’accento umano e poetico con cui sono espressi, diverso è il momento culturale, diversa la concezione filosofica da cui essi nascono.
La sostanza di tali pensieri e di tali lamenti è antichissima, trovasi già nei libri di Giobbe e dell’Ecclesiaste (vanità delle vanità,,. Tutto è vanità), entrambi compresi nell’Antico testamento, e nel De rerum natura di Lucrezio.
Alcuni versi, poi, sono reminiscenza – nel significato e nel tono – di versi di un grande poeta italiano, Petrarca, che ritroviamo inserite spesso nei Canti.
I versi l2-14 (« move la greggia oltre pel campo… ) sono I’eco dei vv. 29-38 della canzone petrarchesca Ne la stagion..; altre reminiscenze sono nei versi 30 e 36 (cfr. ancora la canzone Ne la stagion : nel Petrarca << Ad una ad una annoverar le stelle > nella canzone In quella parte…).
A proposito di quest’ultima reminiscenza scrive il Flora: < qui l'altezza stessa del motivo che il pastore va cantando, cosi diverso dalle ragioni amorose e galanti e divinamente futili per le quali il Petrarca compone la sua meravigliosa canzone, muta l'intima virtù del verso, anche se il Leopardi non ne avesse fatto il musicale rivolto . Certo, sono bastati quel mutamento nell'ordine delle medesime parole e quella soppressione dell'a con lo “spessore " di un'altra ' [5]
Degne di riflessione mi sembrano poi le seguente conclusioni dell'Angelini. [6]
, e del Calcaterra [7]
A Voi, Amiche ed Amici, uno spunto per ulteriori approfondimenti, soprattutto sulle tematiche concernenti le fasi del pessimismo e della poetica leopardiani.
[1] G. Leopardi: Tutte le opere , introduzione e cura di Walter Binni , con la collaborazione di Enrico Ghidetti , Firenze: Sansoni , 1969 (2 volumi)
[2] F. Flora:Tutte le opere di G. Leopardi,Mondadori, Milano, 1962
[3] F. Flora: cit.
[4] Aldo Budriesi: Letteratura: Forme e modelli, SEI, Torino, 1988
[5] Sul tapporto tra la parola leopardiana e la tradizione letteraria osserva ancora il Flora
[6] C. Angelini: Notizie di poeti , Firenze, Le Monnier , 1944
[7] Carlo Calcaterra : Il Barocco in Arcadia e altri studi sul Settecento, 1950