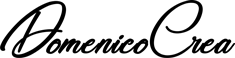G. D’Annunzio: Da Alcyone
La sera fiesolana
Fresche le mie parole ne Ia sera
ti sien come il fruscio che fan le foglie
del gelso ne la man di chi le coglie
silenzioso e ancor s’attarda a I’opra lenta
su l’alta scala che s’annera
contro il fusto che s’inargenta
con le sue rame spoglie
mentre la Luna è prossima a le soglie
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo
ove il nostro sogno si giace
e par che la campagna già si senta
da lei sommersa nel notturno gelo
e da lei beva la sperata pace
senza vederla.
Laudata sii pel tuo viso di perla,
o Sera, e pe’tuoi grandi umidi occhi ove si tace
l’acqua del cielo!
Dolci le mie parole ne la sera
ti sien come la pioggia che bruiva
tepida e fuggitiva,
commiato lacrimoso de la primavera,
su i gelsi e su gli olmi e su le viti
e su i pini dai novelli rosei diti
che giocano con l’aura che si perde,
e su ‘l grano che non è biondo ancora
e non è verde,
e su ‘l fieno che già patì la falce
e trascolora,
e su gli olivi, su i fratelli olivi
che fan di santità pallidi i clivi
e sorridenti.
Laudata sii per le tue vesti aulenti,
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il
il fien che odora!
Io ti diro verso quali reami
d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti
eterne a l’ombra de gli antichi rami
parlano nel mistero sacro dei monti;
e ti dirò per qual segreto
le colline su i limpidi orizzonti
s’incùrvino come labbra che un divieto
chiuda, e perché la volontà di dire
Ie faccia belle
oltre ogni uman desire
e nel silenzio lor sempre novelle
consolatrici, sì che pare
che ogni sera l’anima le possa amare
d’amor più forte.
Laudata sii per la tua pura morte
o Sera, e per I’attesa che in te fa palpitare
le prime stelle!
METRO: tre strofe di quattordici versi di varia misura, ciascuna seguita da una breve strofa di tre versi liberi, di cui il primo rima con l’ultimo della strofa precedente.
Da certi appunti contenuti nel taccuino di D’Annunzio, sembra che lo spunto de La sera fiesolana sia derivato al poeta dalle emozioni provate durante un pellegrinaggio ad Assisi insieme ad Eleonora Duse. Il riferimento però non è necessario per comprendere una lirica che ha completa autonomia, tanto che muta il dato geografico e rende assente l’interlocutrice cui il poeta si rivolge, solo spettatrice di un discorso che resta interno al poeta medesimo.
L’io del poeta si fa natura, si compenetra per pura forza di sensazioni nello spirito fresco e dolce della sera; la natura a sua volta si personifica.
Le laudi di tre versi che si alternano alle tre strofe, riprendono il Cantico di Frate Sole di Francesco d’Assisi che iniziava con laudato sii…, ma non in modo sacro ma assolutamente profano. Al contrario della spiritualità francescana si contrappone una personificazione della sera con sembianze femminili. Essa infatti è presentata come una donna che ha il viso perlaceo, le vesti profumate e che odora di fieno.
La lirica non presenta uno sviluppo logico-discorsivo, ma procede attraverso accostamenti di immagini che fluiscono l’una dall’altra, con una catena ininterrotta di analogie.
Tra l’elemento naturale e quello umano si stabilisce una reciproca corrispondenza per cui la natura tende ad antropomorfizzarsi, mentre gli esseri umani si naturalizzano.
Il poeta a Fiesole descrive il sopraggiungere quieto sulla campagna della sera, umanizzata e trasfigurata nella donna amata: “Laudata sii pel tuo viso di perla, | o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace | l’acqua del cielo!” (vv-15-17). Non si tratta di una poesia narrativa, ma sono presenti solo accostamenti di immagini di paesaggi e piante che richiamano i temi dannunziani dell’estasi amorosa, dell’immedesimazione dell’uomo con le cose e con la natura, perché come afferma in un’intervista D’Annunzio stesso “le cose non sono se non i simboli dei nostri sentimenti, ci aiutano a scoprire il mistero che ciascuno di noi in sé chiude”.
Nella prima strofa, nella quale le parole del poeta vengono subìto stabilite come oggetto del discorso, la similitudine sposta l’attenzione sul dato naturale determinando un’immagine che, per addizioni successive, si compone come Scena autonoma rispetto agli intenti analogici iniziali. È come se il poeta si lasciasse invadere dal piacere di quel procedimento che fa scaturire, in un crescendo estetizzante, un’immagine dall’altra, allontanandosi dalla coerenza logica iniziale finché la luna – anzi il diafano chiarore che, velando le cose, ne rivela la misteriosa presenza – riconduce la descrizione all’interno del campo semantico relativo alla sera.
La strofa successiva parte anch’essa da una similitudine incentrata sulle parole del poeta, in questo caso assimilandole però alla pioggia primaverile che, come liquido vivificante, si riversa dolcemente su ogni cosa.
La terzina centrale, riprendendo il motivo del fieno tagliato, ripropone e ribadisce l’esistenza di una legge naturale, fatta di cicliche trasformazioni, nella quale si inserisce il lavoro umano, assecondando tale legge e confondendosi con essa. Allora la bellezza ed il mistero si assoceranno definitivamente ed esplicitamente alla natura, resa oggetto di un amore che di continuo si accresce, luogo di un ritorno all’ origine.
L’ultima terzina evidenzia finalmente un momento di pausa, di ricomposizione delle percezioni e delle fascinazioni, in quella pura morte che, conquistata come momènto di pace, viene immediatamente liberata dalle possibili compromissioni con una fine eterna: essa si fa attesa della notte, nuovo flusso di sensazioni, del quale le prime stelle sono la sicura promessa.
Sempre in quest’ultima strofa si trova una personificazione delle colline fiesolane, che diventano labbra di donna pronte ad aprirsi per rivelare un segreto. Questo è il mistero della natura a cui il poeta anela e in cui si abbandona, anche se manca ancora quel totale assorbimento e comunione con la natura a cui si assiste nella Pioggia nel pineto.
D’Annunzio affrancherà la frase dalla punteggiatura, con una scelta non del tutto nuova, ma sostanzialmente ardita, in quanto abolire l’interpunzione significa eliminare la scansione «logica» del periodo a favore dell’elemento musicale e suggestivo.
Ridotto a puro elemento tematico, l’artificiale perde quindi ogni rapporto con quelle sostanziali implicazioni ideologiche ed estetiche che ne avevano determinato l’assunzione all’interno delle poetiche decadenti e non evidenzia più il definitivo distacco da un’arte «rappresentativa».
Se qualcosa si conserva, in D’Annunzio, dell’originaria funzione dell’artificiale, è semmai il desiderio di contrapporre, alla massificante normalità dell’esistenza borghese e della vita pratica, una superiore percezione intellettuale che rifiutava di lasciarsi uniformare alle esigenze di una mediocrità disindividualizzante.
Nell’autore italiano esso si caricò di ben diverse connotazioni ideologiche e, coniugandosi con la teoria superomistica, assunse un significato preminentemente politico del tutto originale.
“Il superuomo dannunziano […] presenta alcune caratteristiche che potrebbero così riassumersi: culto della energia dominatrice sia che si manifesti come forza (e violenza) o come capacità di godimento o come bellezza; ricerca della propria tradizione storica nella civiltà pagana, greco-romana, e in quella rinascimentale; concezione aristocratica del mondo e conseguente disprezzo della massa, della plebe e del regime parlamentare che su di essa è fondato; idea di una missione di potenza e di grandezza della nazione italiana da realizzarsi soprattutto attraverso la gloria militare; giudizio totalmente negativo sull’Italia post-unitaria e necessità di energie nuove che la sollevino dal fango; concetto naturalistico, basato sul sangue e sulla stirpe ed altri elementi fisici, sia della nazione che del superuomo destinato a incarnarla e a guidarla” (C. Salinari).
Per quanto riguarda il principio dell’ “arte per l’arte”, esistono, nella produzione dannunziana, esplicite prese di posizione che sembrano implicare la sostanziale adesione del poeta.
La più famosa è forse quella inserita nel Piacere: “ Il verso è tutto. Nella imitazione della Natura nessuno istrumento d’arte è più vivo, agile, acuto, vario,moltiforme, plastico, obediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile d’un fluido, più vibrante di una corda, più luminoso d’una gemma, più fragrante d’un fiore, più tagliente d’una spada, più flessibile d’un virgulto, più carezzevole d’un murmure, più terribile d’un tuono, il verso è tutto e può tutto. Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire I’indefinibile e dire I’ineffabile; può abbracciare l’illimitato e penetrare I’abisso; può avere dimensioni d’eternità; può rappresentare il sopraumano, il soprannaturale, l’oltramirabile; può inebriare come un vino, rapire come un’estasi, può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro corpo; può, infine, raggiungere l’Assoluto. Un verso perfetto è assoluto, immutabile, immortale; tiene in sé le parole con la coerenza d’un diamante; chiude il pensiero come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere; diviene indipendente da ogni legame e da ogni dominio; non appartiene più all’artefice, ma è di tutti e di nessuno, come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e perpetue. Un pensiero esattamente espresso in un verso perfetto è un pensiero che già esisteva preformato nella oscura profondità della lingua. Estratto dal poeta, seguita ad esistere nella coscienza degli uomini. Maggior poeta è dunque colui che sa discoprire, disviluppare, estrarre un maggior numero di codeste preformazioni ideali. Quando iI poeta è prossimo alla scoperta d’uno di tali versi eterni, è avvertito da un divino torrente di gioia che gli invade d’improvviso tutto I’essere”.
Eredità: Se D’Annunzio godette immediatamente di un notevole successo di pubblico, non furono poche le voci critiche che ben presto si levarono per evidenziare i limiti di quella sua scrittura onnivora e preziosa. Primo fra tutti, B. Croce, nel 1903, dedicò al poeta pescarese un saggio (ora nel IV volume di Letteratura della nuova Italia) nel quale si appropriava della denigratoria definizione di D’Annunzio “dilettante di sensazioni” come chiave per intendere quello che per lui era il sostanziale dualismo della produzione dannunziana, consapevolmente raffinata nella forma, ma sorretta solamente, per quanto riguarda il «contenuto, da un «dilettantismo, non già estetico, ma psichico”. Croce isolava così aree di vera poesia, quando l’autore “fissa lo sguardo limpido e sereno sulle cose” e le contrapponeva ai momenti impoetici della sovrabbondanza retorica e oratoria, o a quelli in cui “le cose” appaiono al poeta “fuori dalle loro connessioni superiori, e sola guida tra esse è il caso e il capriccio o l’allettamento sensuale”.
I1 giudizio fortemente critico di Croce e le compromissioni di D’Annunzio con I’ideologia fascista hanno determinato per lungo tempo un distanziamento di critici e letterati nei confronti del poeta abruzzese, fino al punto che “dannunzianesimo” è divenuto termine fondamentalmente spregiativo, sinonimo di vuota oratoria, di magniloquenza, di un discorso tutto risolto in demagogici orpelli retorici. Solo recentemente la produzione di D’Annunzio è stata rianalizzata e rivalutata nel suo complesso, portando non solo alla ricomposizione di quel dualismo che la critica degli anni Trenta aveva instaurato fra il D’Annunzio “solare”, falso e oratorio (tranne che negli sprazzi lirici dell’Alcyone) e il D’Annunzio “notturno”, sincero nel ripiegamento interiore e nello sfogo memorialistico, ma anche al riconoscimento del profondo influsso esercitato dallo scrittore sulla letteratura del Novecento italiano.